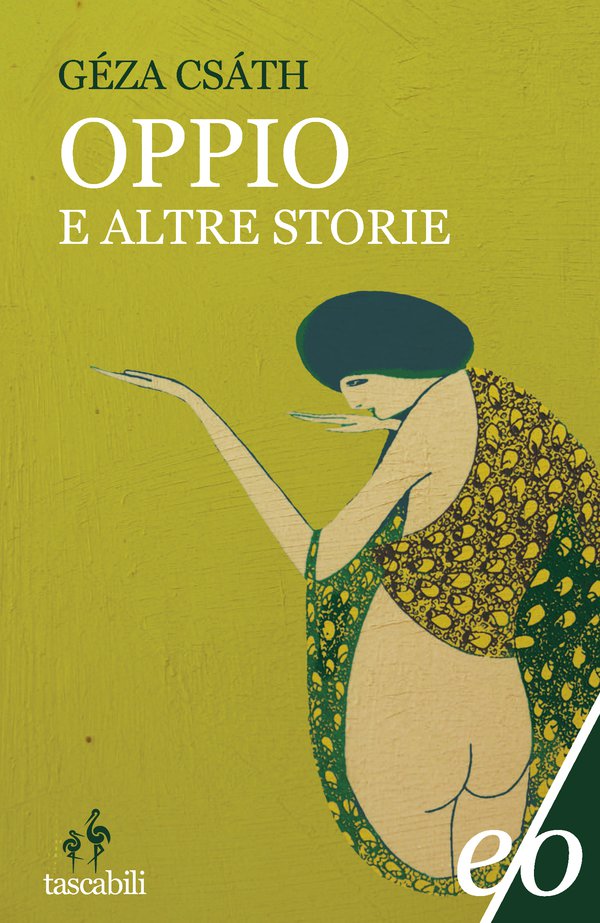Jessica Alfieri
Jósef Brenner, in arte Géza Csáth, nasce nel 1887 in una famiglia agiata di origini borghesi; l’unico evento traumatico della sua infanzia sembra essere la morte della madre all’età di otto anni e l’arrivo di una matrigna poco amata. Nel corso dell’adolescenza e successivamente nei primi anni dell’età adulta, si cimenta in vari campi artistici: la pittura, la musica – suona il violino e compone brani – e la scrittura. In seguito, si iscrive alla facoltà di medicina all’Università di Budapest, lasciando perplessi tutti quanti conoscevano le sue attitudini artistiche. In una lettera al cugino e letterato ungherese Dezső Kosztolányi giustifica la sua decisione come segue:
“Una tremenda maledizione grava sull’animo di tutti noi, nelle cui vene scorre il sangue dei Brenner e che ci troviamo inoltre cinti dall’abbraccio del XX secolo; ci siamo insediati nella vita in maniera malsana e sbagliata, con tutta quella letteratura divorata a grandi cucchiaiate […]. La nostra anima, ragazzo mio, è come l’ago di una bussola che gira all’impazzata nel mezzo di una bufera, sconquassata da tuoni e saette, eppure potrebbe starsene in santa pace, se solo non possedesse una sensibilità magnetica così sviluppata.” (Dér, 1980, p. 83.)
L’approdo alla medicina è sentito, quindi, come una necessità quasi fisiologica ed è alla medicina che vengono affidati due ruoli fondamentali: da una parte, è antidoto che conferisce freddezza e lucidità in contrapposizione alla propria eccessiva suggestionabilità; dall’altra parte, è mezzo per assecondare i propri incubi. Il 1909 è l’anno dei primi studi su Freud e anche della stesura della raccolta Oppio e altre storie, in cui l’ormai Géza Csáth fa convergere, sotto forma di racconto, i suoi pensieri a metà strada tra la realtà della mente e la realtà della vita quotidiana. Nonostante Csáth abbia da poco iniziato a far uso di morfina per affrontare i suoi tormenti interiori, l’oppio del titolo fa riferimento alla sua naturale sensibilità verso i fenomeni esterni, unita alla sua profonda capacità di straniamento. Gli elementi anticipatori della raccolta si possono riconoscere nella conclusione di una novella scritta all’età di sedici anni, in cui si legge:
“Oh, vita, il tuo crescendo grandioso mi colma di estasi e di profonda soddisfazione. Che il crescendo sia prolungato, lento tanto da estenuarci i nervi, ma ininterrotto e veramente magistrale. Affinché, un attimo dopo che il fortissimo avrà raggiunto il suo culmine più superbo e al tempo stesso più luttuoso, io possa dire, in dispregio a ogni speranza ingannevole e vana: è stata una musica bella, una musica divina, così grandiosa e compiuta che non ho più nessuna voglia di ascoltare il resto.” (p. 66)
Nonostante sia stata la medicina a concedere a Brenner la possibilità di discernimento razionale rispetto a questa realtà che lo perseguita, è la scrittura il mezzo concreto cui Csáth si dedica per liberarsi dei suoi stati di tensione. I suoi racconti rappresentano, da questo punto di vista, l’oggettivizzazione di tale insopportabilità.
Le narrazioni all’interno di Oppio e altre storie sono tra loro scollegate, si possono leggere in qualsiasi ordine, saltarne alcune, concentrarsi più volte su altre; si possono leggere dall’ultima alla prima o, viceversa, in senso tradizionale. I personaggi come le ambientazioni sono sempre diversi, c’è, però, un doppio filo conduttore che sottende da una parte la vita delle donne e dall’altra quella degli uomini. Infatti, come avviene nella vita di Csáth, gli uomini soffrono a causa delle limitanti convenzioni della propria quotidianità che comunque non si sforzano di cambiare, non sono eroi in questo senso. Quando raggiungono l’apice della sopportazione provano a sfuggire alla realtà attraverso tentativi disperati, rifugiandosi nei sogni, nell’alcol o nelle droghe, in particolare l’oppio. Al lettore possono talvolta apparire assurdi, finché non diventa evidente che la loro assurdità è solo una risposta ad un mondo assurdo contro cui non possono nulla.
Il mondo delle donne è a sua volta dicotomico: c’è il mondo delle donne reali e quello delle donne immaginarie. Nell’opera di Csáth sono le donne la spina dorsale dei racconti, in quanto da una parte rappresentano perfettamente il mondo vuoto e superficiale della classe media che Csáth critica e, dall’altra, sono spesso la spiaggia a cui approdano gli antieroi in cerca di rifugio. Le donne reali non hanno aspirazione né desiderio di vivere una vita diversa dalla loro, non mettono in discussione nessuno dei valori prestabiliti di cui esse stesse sono beneficiarie. Dal punto di vista economico dipendono completamente dai mariti e non hanno propensioni artistiche; sono, inoltre, indifferenti rispetto all’ambiente che le circonda, elemento che rende difficile al lettore provare compassione verso di loro, anche quando sono vittime.
Sono gli uomini stessi a creare le loro donne da sogno, il cui requisito fondamentale è di non avere pretese ed essere il meno esigenti possibile. Al di là della figura stereotipata della madre (quasi sempre defunta) pronta a tutto – in una dimensione in cui la morte non impedisce di agire –, le altre eroine del mondo onirico di Csáth irradiano anche eterna gentilezza e comprensione. Portatrice emblematica di tali qualità è il primo amore del Mago nel racconto La morte del mago. All’alba del Mercoledì delle Ceneri, il mago, nonostante gli incantesimi con cui ha tentato di salvarsi dall’intossicazione da oppio, si adagia agonizzante su due sedie in attesa che la morte lo prenda e ponga fine alla sua sofferenza. Con gli occhi chiusi, vede arrivare al proprio capezzale alcuni parenti e alcune donne defunti, tra cui “l’unica donna che avesse mai amato in vita sua.”
“Era un po’ meravigliato, perché si trattava di una vecchia storia che risaliva a cinque o sei anni prima – e la ragazza non era cambiata minimamente.
Indossava una sottana corte e il suo viso tenero e fragrante non era invecchiato come quelli delle altre donne.” (p. 58)
Essendo l’unica a non aver mai preteso niente in cambio da lui, è anche l’unica con cui il mago trova un riscontro emotivo in maniera desessualizzata. In questo racconto, è l’eccessivo uso di oppio ad avviare il processo di decadimento fisico del protagonista ed è una giovane donna dai tratti eternamente floridi ad accoglierlo definitivamente dall’altra parte.
Un’altra storia che riassume in sé le sfumature femminili presenti nella raccolta di Csáth è Matricidio. Sia la madre, sia la prostituta vengono rifiutate e viste l’una come il riflesso rovesciato dell’altra. La figura della prostituta, almeno a questa altezza storico-cronologica, ha più dignità di quella della madre, in quanto, al contrario di quest’ultima, ha un guadagno economico che non la rende completamente dipendente da un uomo. Inoltre, la madre viene oggettivizzata nella misura in cui rappresenta semplicemente il mezzo con cui arrivare alla prostituta – sono suoi i gioielli che i figli portano in pagamento a quest’ultima, a sua volta oggetto. I protagonisti sono due giovani fratelli, “dei ragazzi belli e floridi” rimasti orfani di padre, che passano spesso la notte con ragazze immaginarie, evocate dalla loro stessa fantasia.
“Scivolarono nella stanza senza far rumore, sfiorando appena i vetri con le schiene vellutate, si avvicinarono ondeggiando e fluttuando per posarsi infine accanto a loro adagiandosi sui cuscini e sulle coperte. Strusciavano il collo contro il viso dei ragazzi offrendo la gola alle loro labbra, quindi tornavano a ritrarsi con gesti lievi, pigri e voluttuosi. Rimasero tutta la notte con loro nella stanza. Si prendevano per mano con movenze sinuose, lievitavano verso la finestra con un sorriso sulle labbra, quindi s’accostavano di nuovo serpeggiando, si adagiavano sui ragazzi e li cingevano con le braccia. Solo quando la luce del giorno irruppe nella stanza con i suoi raggi caldi e splendenti, si allontanarono passando dalla finestra con un lento fruscio trasognato e incerto, per dissolversi infine nell’aria fresca del mattino.” (p. 66)
Nonostante la crudeltà e follia a cui sono sottoposti, la realtà di questi personaggi è pur sempre accettabile, una volta compreso il disagio esistenziale da cui origina. Il narratore sembra essere cosciente della condizione con cui il lettore deve confrontarsi ed è per questo che, nel dispiegare tematiche crude e macabre, si appresta ad accompagnarlo attraverso gli eventi con l’atteggiamento di chi tiene per mano qualcuno durante un’esperienza spaventosa. Nel racconto intitolato Paolo e Virginia si legge:
“Vorrei narrarvi la storia di Paolo e Virginia. Ma c’è qualcosa che mi preoccupa. Il lettore, lo so bene, incomincia sempre col dare una rapida occhiata al racconto. Se si accorge che verso la fine c’è qualche particolare appetibile e vivace – ad esempio un battibecco concitato – che l’autore ha descritto in modo tale da calamitare l’attenzione, può darsi che gli venga il gusto di leggere la storia dall’inizio alla fine. In caso contrario ciò non avverrà. Per scrivere questa storia vorrei ricorrere perciò a uno stile elettrizzante e inconsueto, costellandola di mille piccoli particolari pittoreschi. E tuttavia non posso. Ora come ora, infatti, sono incapace d’individuare in essa alcunché di elettrizzante. A prescindere dagli ultimi accordi, è una vicenda che mi sembra amabile e linda come un’aria di Mendelssohn.” (p. 30)
Nell’esprimersi in questi termini, il narratore fa entrare il lettore nel tempo della narrazione, ovverosia nel momento designato per il racconto, spiegando le modalità con cui lo farà e le motivazioni che lo spingono a farlo. Questo tempo si trova sospeso a metà strada tra la realtà contemporanea al lettore e il tempo del racconto vero e proprio ed è questo il tempo in cui il lettore deve essere disposto a spogliarsi delle armature convenzionali che lo portano a discernere la realtà in maniera razionale e logica. Grazie alle informazioni fornite come preambolo alla storia di Paolo e Virginia, questo primo approccio tra narratore e lettore si potrebbe considerare uno schermo pronto a mostrare una pellicola, dove la voce narrante è una voce fuoricampo.
In modo molto spontaneo prosegue:
“Siamo in ottimi rapporti d’amicizia, e non avrei il cuore di usarli come dei pupazzi, perché recitino la loro storia sulla carta come due perfetti sconosciuti. Quindi ve la racconterò così come viene.” (p. 30)
“C’è quindi un occhio di riguardo sia per il lettore, che non sa cosa lo aspetta, sia per gli amici del narratore, i protagonisti, che vengono trattati come persone in carne ed ossa della cui vita si sta semplicemente narrando un evento. Le riflessioni metaletterarie di cui sopra continuano:
Non vedo a che cosa servirebbe elencare ad uno ad uno i tormenti sofferti da Paolo e Virginia. Lo scrittore non deve torturare le persone di cui scrive né quelle a cui si rivolge; è vero che così raggiungerebbe forse effetti più clamorosi, però su certe cose è meglio fare silenzio.” (p. 33)
Csáth crea un ponte tra racconto e lettore che solo il narratore può oltrepassare, rivolgendosi all’uno o all’altro a seconda delle necessità narrative. Questo aspetto della sua scrittura potrebbe trovare una causa nella carriera “altra” dell’autore, ovvero quella di psichiatra. Molti dei disturbi presentati, infatti, sarebbero stati ispirati a casi con cui il Dottor Brenner è effettivamente venuto in contatto, per andare a riflettersi, poi, nelle storie della raccolta definite “cliniche”.
Padre e figlio è uno di questi racconti “clinici”, in cui un figlio si reca all’Istituto di anatomia per reclamare il cadavere del padre da poco defunto e dargli una degna sepoltura. Dato che sarebbe stato usato dagli studenti per fare pratica, il corpo era già stato bollito fino a rimanere spoglio di tutta la sua carne. Ciò che resta al giovane è solo lo scheletro:
“Reggeva il suo insolito fardello procedendo spedito a passi regolari, e teneva gli occhi bassi come se si vergognasse un po’ di suo padre.
Qualche studente ritardatario lo vide attraversare il grande corridoio con lo scheletro che ballonzolava tutto e sembrava esibirsi in una strana danza, mentre l’uomo dal volto glabro lo teneva stretto a sé in un goffo abbraccio. Il figlio, il padre.” (p. 98)
La scena ricorda, con grottesca ironia, la fuga di Enea con il padre, Anchise, sulle spalle; la differenza per Csáth, però, è che il passato rappresentato dal genitore defunto non è altro che un cumulo di aride ossa, che non acquisterà significato nemmeno una volta datagli sepoltura. Al contrario, nel privare l’Istituto di anatomia di questa risorsa scientifica, priva il corpo stesso della sua funzione, in questo caso, educativa, che di norma è anche la funzione ricoperta dalla figura del genitore. Volendo allargare l’interpretazione, si potrebbe includere tra i concetti di cui il padre è metafora anche la figura dell’Imperatore, dell’autorità istituzionale, vista dagli occhi di Csáth come un cumulo di forma privo di alcuna sostanza in procinto di collassare sotto il mucchio di corpi lasciato dalla Prima Guerra Mondiale, a cui l’autore ungherese prenderà parte.
Nella seduta probabilmente psichiatrica di Silenzio nero, un medico ascolta la storia del paziente riguardo il suo fratellino più giovane, Richard, che pare essere andato incontro ad una radicale trasformazione dal giorno alla notte. Il mutamento di Richard, causato dal silenzio nero di cui il titolo, sembra aver influenzato anche l’abitazione in cui vive con la famiglia:
“La sua crescita avvenne all’improvviso.
[…] Il nostro lindo cortiletto con le sue pianticelle di rosa si riempì di erbacce nauseabonde e maleolenti. Le tegole precipitarono dal tetto e l’intonaco si sgretolò cadendo dai muri.
E vennero notti terribili. Nel mezzo dei loro sogni, le mie sorelline scoppiavano in un pianto dirotto. Mio padre e mia madre accendevano la candela e si fissavano con volti vacui e privi di sonno. Nessuno sapeva che cosa stesse accadendo né che cosa sarebbe accaduto.” (p. 9)
Dopo aver torturato con fuoco lento il gatto di una delle sorelle, Anikó, aver derubato un mercante e dato la casa alle fiamme, Richard viene portato in manicomio, dal quale evade per tornare a casa la sera stessa. A questo punto, è chiaro a tutti i membri della famiglia che una natura oscura si è impossessata di lui e lo spinge ad agire secondo un volere che non può controllare. Il narratore decide di strangolare il fratello nel sonno per porre fine alle sue e altrui sofferenze, ed è con la morte che:
“Il corpo ormai freddo di Richard si stava rimpicciolendo tra le mie mani.
Accesi la candela.
Nel letto giaceva un bimbo tenero e piccino. Col volto bluastro coperto di chiazze violacee.” (p. 13)
Viene da chiedersi se i fratelli siano effettivamente due oppure soltanto uno in preda a disturbo dissociativo per cui il protagonista racconta del proprio esorcismo su se stesso, magari in sogno nella sua stanza di manicomio.
“Vorrei tanto non udire più quella risata, perché ogni volta mi prende un gran male alla testa e nelle spalle, e non voglio più vedere gli occhi scuri del piccolo Richard sbarrati sull’infinito; perché sento ogni volta un nodo che mi stringe alla gola e non mi lascia dormire. Ora che ci penso, signor dottore, non riesco mai a dormire come si deve.” (ibid.)
La raccolta presentata fin qui di Géza Csáth racchiude una costellazione di attitudini umane, seppur macabre. Lo strumento letterario è il mezzo per ovviare al tabù della società ed esternare certi sconvolgimenti interiori, fino ad esorcizzarli con un lettore che ha scelto di entrare nel mondo allucinatorio dello psichiatra-scrittore non necessariamente per trarne godimento. Infatti, viene in mente un’altra figura letteraria con cui si è costretti a confrontarsi: Moosbrugger, l’assassino di prostitute de L’uomo senza qualità di Robert Musil. In uno dei primi approcci del protagonista Ulrich, con il caso d’omicidio, il narratore porta il suo personaggio ad una riflessione che riguarda, in realtà, qualunque cittadino.
Considerando Moosbrugger non come assassino, bensì come risultato di determinate condizioni sociali, economiche e familiari che lo hanno portato ad assumere un certo comportamento, e come vittima delle voci della sua stessa mente, Musil avvicina un qualsiasi essere umano “civile” alla natura mostruosa del suo personaggio, lasciando intendere che chiunque potrebbe trovarsi al suo posto. Géza Csáth, un paio di decenni prima del romanzo di Musil, fa entrare il suo lettore nella stessa malattia che attanaglia sia lui stesso, che Moosbrugger e la società del primo Novecento. Lasciando che esperisca una follia omicida portata alle estreme conseguenze, Csáth rompe le barriere che vedono nella famiglia un luogo sacro; nel bambino il simbolo dell’innocenza; nella donna un essere senza scrupoli oppure, al contrario, un luogo sicuro, giacché può essere entrambi. La follia con cui Csáth permette di confrontarsi riguarda anche quella della vita quotidiana che sfocia, per essere soffocata, nella dipendenza da oppio.
Bibliografia:
Dennis Poupard, Twentieth-Century literary criticism, Detroit, Gale Research Co, 1984.
Géza Csáth, Tavaszok in Ismeretlen házban, vol. 1, Újvidék, Forum, 1916.
Géza Csáth, Oppio e altre storie, Roma, Edizioni e/o, 1998.
Jascha Kessler e Charlotte Rogers, The magician’s garden and other stories by Géza Csáth, in “World literature today” Vol. 54 No. 4, Oklahoma, 1980, pp. 673-674.
Zoltán Dér, Ikercsillagok, Novi Sad, Forum, 1980.
Sitografia:
https://www.britannica.com/biography/Geza-Csath (ultima consultazione: 15/11/2021)
https://taz.de/Untergangsprosa/!1778152/ (ultima consultazione: 10/11/2021)
Apparato iconografico:
Immagine di copertina e Immagine 1: https://jelen.media/kultura/a-varazslo-levelei-813
Immagine 2: http://signorformica.blogspot.com/2010/12/geza-csath-cuentos-que-acaban-mal.html
Immagine 3: https://www.edizionieo.it/book/9788866321088/oppio-e-altre-storie